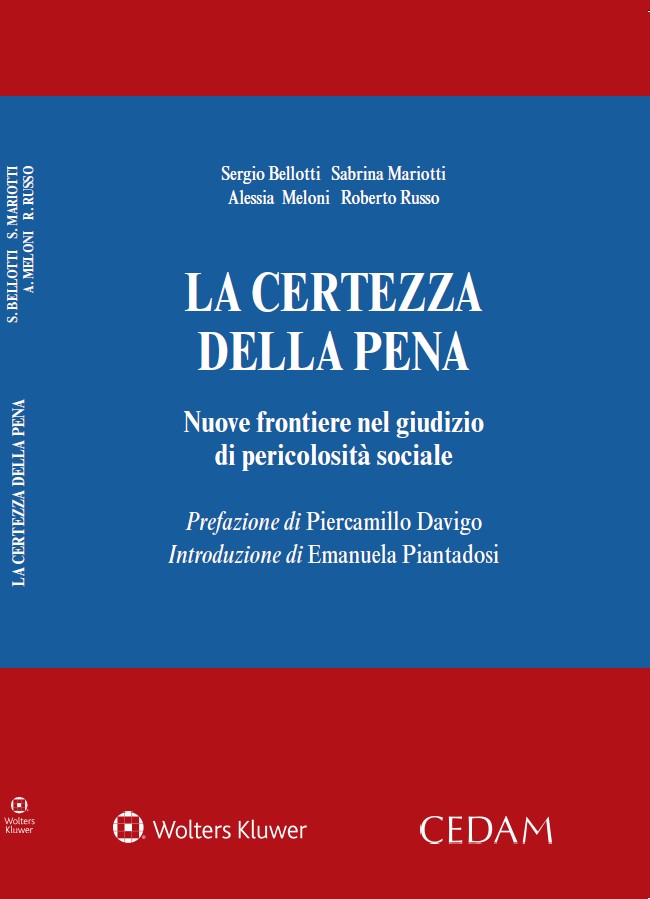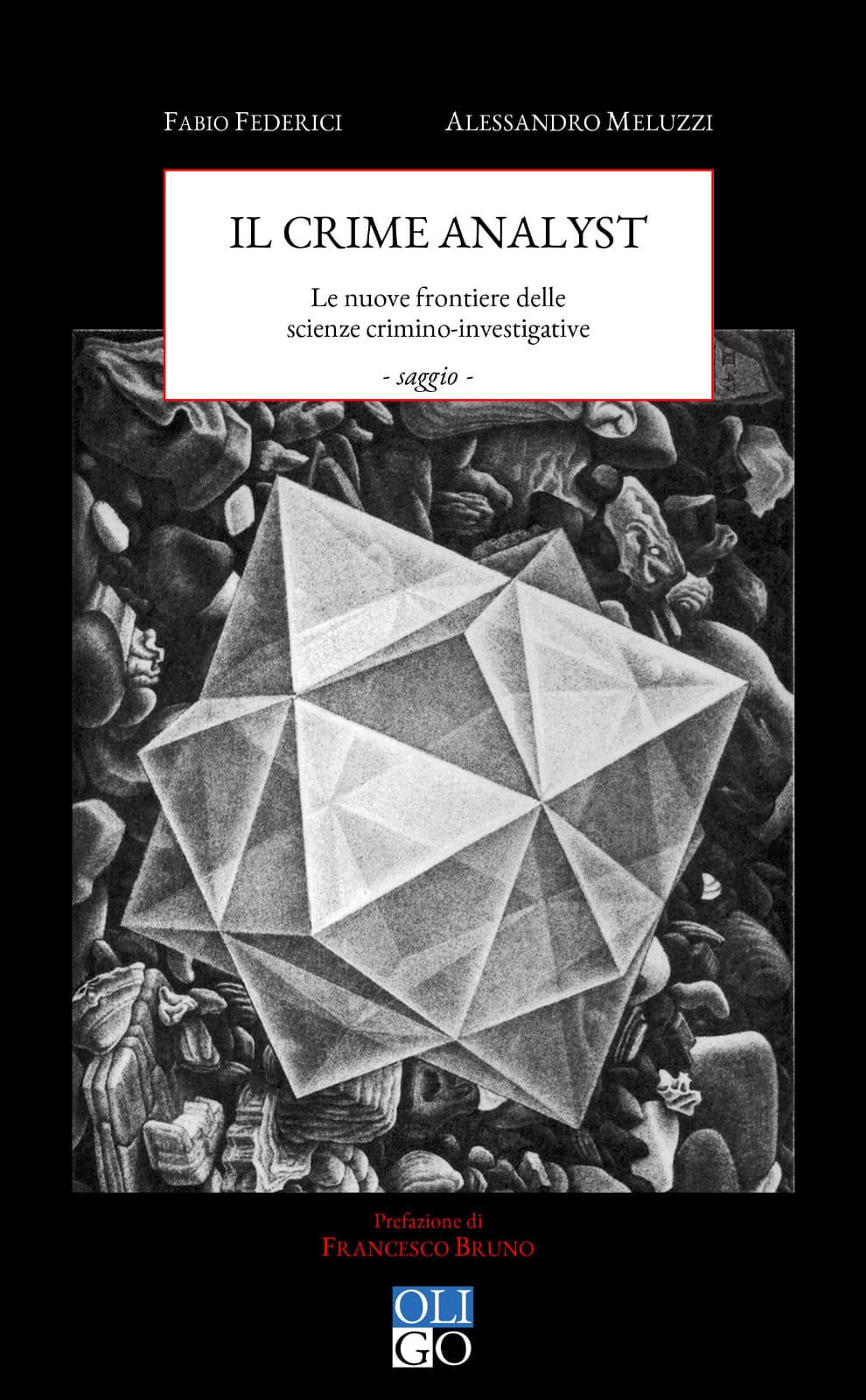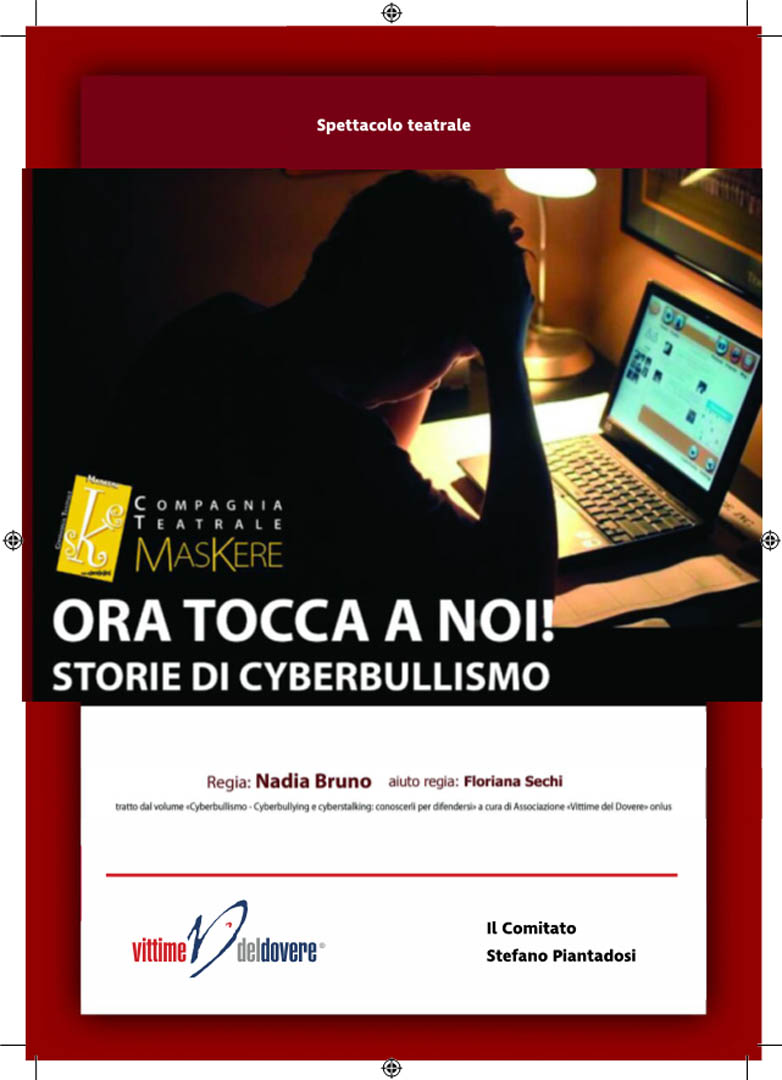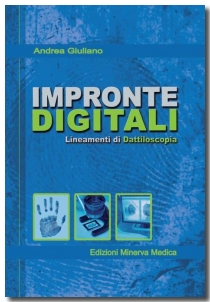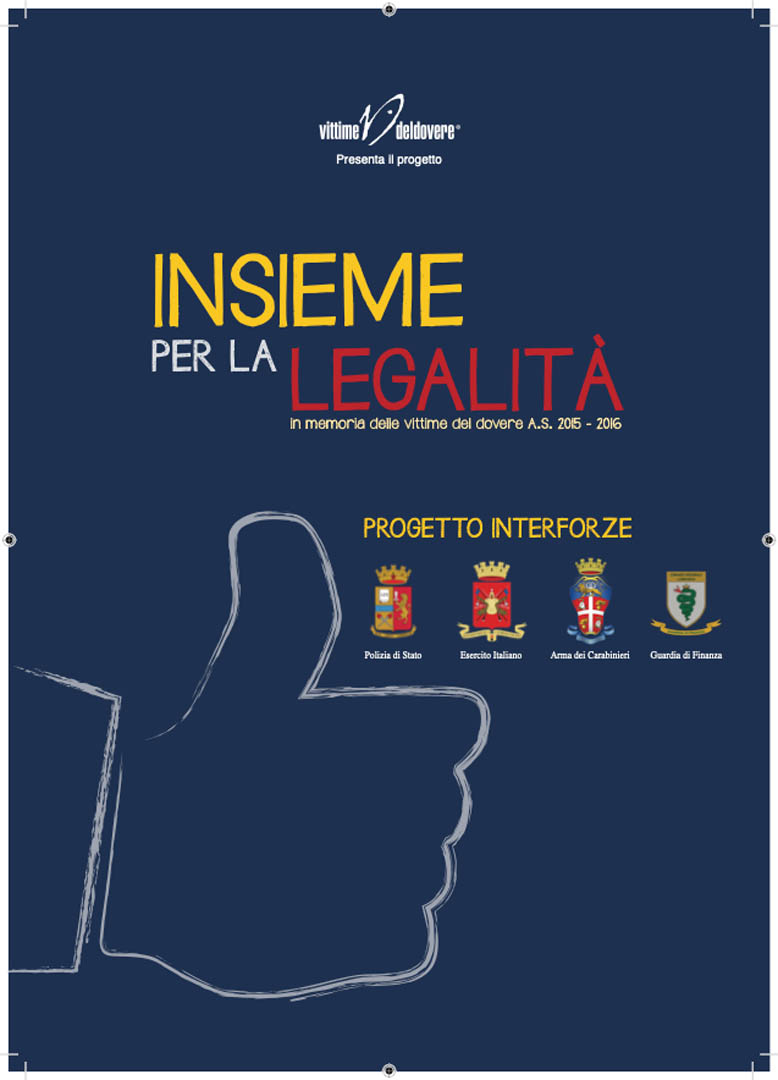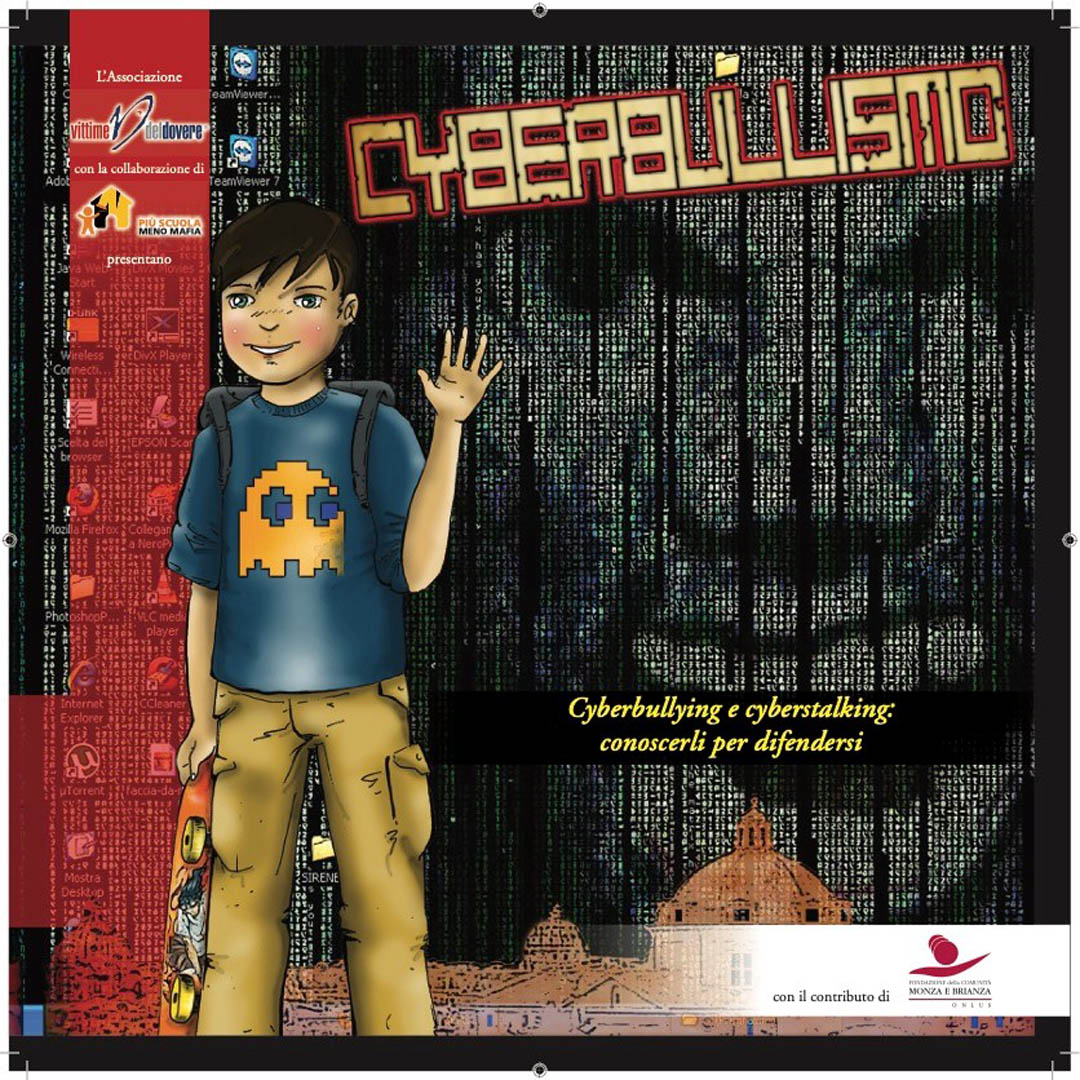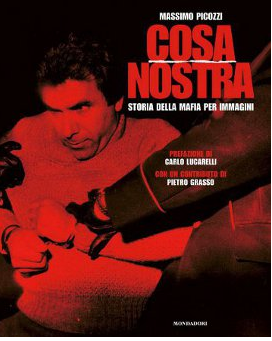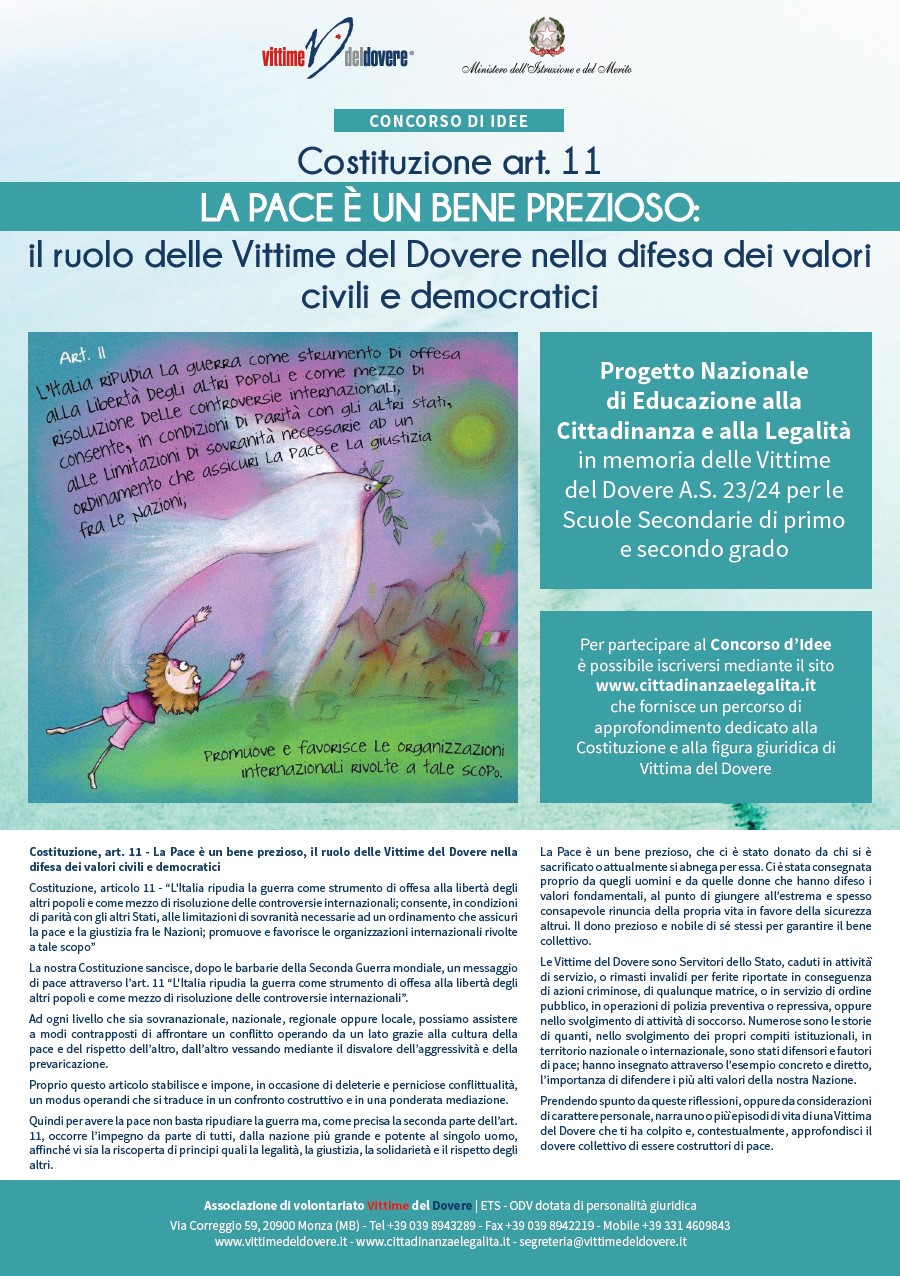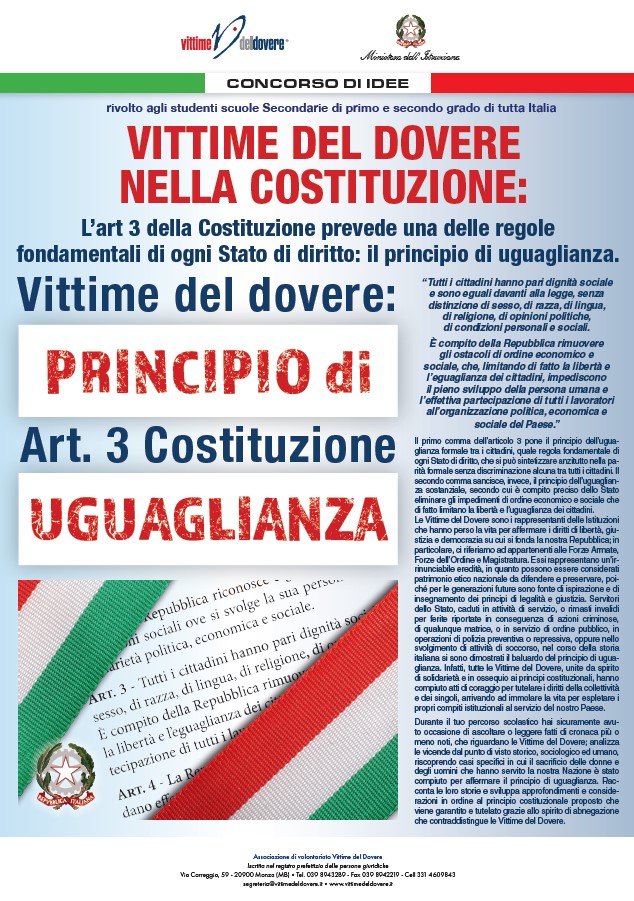Vittime del Dovere ETS-ODV
C.F.94605940157
via Correggio 59
20900 Monza (MB)
Tel. 039 8943289
Fax 039 8942219
Cell 331 4609843
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it
Vittime del Dovere La storia I traguardi raggiunti Organizzazione Attestati Il nostro logo Diventa un associato Consulenza legale Centro di sostegno Elenco Soci Onorari Bilanci I calendari
educazione alla legalità 10° Anniversario Libri e pubblicazioni Lotta alle mafie Monumento Vittime del Dovere Cronologia delle attività
Vittime Legislazione Atti parlamentari Entrate derivanti
da Enti Pubblici Convenzioni
e protocolli
con Enti pubblici Convenzioni
e protocolli
con Enti privati Donazioni Campagna sociale Privacy policy Numeri & link Dona il 5 x mille Resoconto 5 x mille

 Incominciò con una lettera. Erano gli anni novanta quando mi spedì la prima. Una grafia ordinata, come la insegnano a scuola. Con l’indicazione del mittente: Irene Ferrari ved. Di Pietro. Mi colpì il cognome, che a quei tempi rimbalzava senza sosta dagli schermi televisivi. E quel “ved.”, che non capii subito che cosa significasse. Aprii la lettera con curiosità. Dentro c’era una storia drammatica. Sono la vedova di un maresciallo dei carabinieri, spiegava l’autrice. Mio marito si chiamava Giorgio Di Pietro (in foto). E’ stato ucciso durante una rapina. Il mondo lo ha dimenticato e io ho due figli da allevare ed educare. Le risposi, lei mi venne a trovare in università. Irene Ferrari mi apparve donna semplice e minuta. Un fare modesto, deferente come l’hanno spesso i familiari delle vittime quando si sentono in colpa per la loro condizione. Ma appariva pure decisa a non farsi schiacciare ai margini, anche se quella era forse la parte che le toccava nel copione tante volte collaudato.
Incominciò con una lettera. Erano gli anni novanta quando mi spedì la prima. Una grafia ordinata, come la insegnano a scuola. Con l’indicazione del mittente: Irene Ferrari ved. Di Pietro. Mi colpì il cognome, che a quei tempi rimbalzava senza sosta dagli schermi televisivi. E quel “ved.”, che non capii subito che cosa significasse. Aprii la lettera con curiosità. Dentro c’era una storia drammatica. Sono la vedova di un maresciallo dei carabinieri, spiegava l’autrice. Mio marito si chiamava Giorgio Di Pietro (in foto). E’ stato ucciso durante una rapina. Il mondo lo ha dimenticato e io ho due figli da allevare ed educare. Le risposi, lei mi venne a trovare in università. Irene Ferrari mi apparve donna semplice e minuta. Un fare modesto, deferente come l’hanno spesso i familiari delle vittime quando si sentono in colpa per la loro condizione. Ma appariva pure decisa a non farsi schiacciare ai margini, anche se quella era forse la parte che le toccava nel copione tante volte collaudato.
Il marito della signora Irene comandava la stazione distaccata di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Ed era stato ucciso un sabato di maggio del 1984. Più precisamente: quel sabato era stato ferito mortalmente, perché sarebbe spirato dopo pochi giorni in un reparto di rianimazione. Con un collega aveva rincorso due rapinatori, uno dei quali lo aveva fermato con un fucile a canne mozze sfigurandolo in viso. Aveva 46 anni, il maresciallo. I giornali locali avevano accompagnato la notizia della sua morte con la consueta nota di cronaca: “lascia una vedova e due figli piccoli”.
L’anno dopo alla memoria di Giorgio Di Pietro fu conferita la medaglia d’argento al valor militare per avere affrontato i malviventi in un conflitto a fuoco “con determinazione e sprezzo del pericolo”. La motivazione aveva avuto per lui belle parole: “Luminoso esempio di elevate virtù militari e di dedizione al dovere, testimoniato con l’olocausto della vita”. E poi: “Vittima del dovere”. E proprio questo era il rovello della signora, passati ormai diversi anni, davanti alla difficoltà di allevare i due figli, Piermario e Roberto, farli studiare, farli vivere senza altre privazioni oltre quella, già immensa, del padre. Si era rivolta a me e chissà a quante porte aveva bussato e stava bussando. “Vittima del dovere”. Sempre con l’aria di chi non voleva prendersi licenze mi rivolgeva la domanda che la angustiava. Ma perché a suo marito e ai servitori dello Stato come lui non venivano riconosciute le stesse provvidenze riservate alle vittime del terrorismo e della mafia? Perché “figli e figliastri”, “serie A e serie B”, diceva, a seconda di chi ha sparato? Non bisognava riconoscere soprattutto i meriti, i rischi corsi consapevolmente? La signora Irene aveva pudore a dirlo, perché non voleva svilire le morti di altri innocenti in divisa. Ma a volte i terroristi avevano ucciso a freddo, senza che il carabiniere o il poliziotto colpito avesse intenzionalmente, in quel determinato momento, rischiato la vita. Suo marito invece, buttandosi all’inseguimento di gente armata, l’aveva ben fatto. Perché gli spettava di meno? Ricevetti le sue lettere precise e ordinate per qualche anno. Mi chiese consiglio per uno dei suoi figli. I ragazzi crebbero, allevati al culto dell’onestà, e non fu una fiaba.
La ritrovai dopo molti anni mentre ero in parlamento. Aveva incontrato persone che si ponevano le sue stesse domande, tra cui Emanuela Piantadosi, un architetto figlia anche lei di un maresciallo dell’Arma ucciso in servizio nel 1980 e che si era messa alla testa di quella grande causa comune. Insieme stavano fondando una associazione, quella delle “Vittime del dovere”, che presentarono a un convegno in una sala della Camera dei deputati nel 2007. Decine di familiari, un piccolo pugno di parlamentari. La signora Irene non era più sola. L’altro giorno l’associazione ha compiuto i suoi dieci anni. Nel frattempo è arrivato il riconoscimento dell’equiparazione, anche se non ancora integrale. Quando l’ho vista ci siamo abbracciati a lungo. Lei era felice, onorata da alti ufficiali, applaudita e fotografata, dopo che la fanfara dei carabinieri aveva suonato per le vittime. Ancora modesta, ancora vestita di nero. “I miei ragazzi hanno fatto carriera, sa? Uno è a Londra, l’altro in Lussemburgo, due grandi banche. E tutti e due hanno chiamato il primogenito Giorgio”, mi ha sussurrato con orgoglio. A quel punto ho pensato che questa storia dovesse essere conosciuta. La storia di Irene Ferrari ved. Di Pietro, la donna che ha scavato la roccia con le mani.
(scritto sul Fatto Quotidiano del 18.2.17)
Sostieni l'associazione!
Fai una donazione con
IT33A0760101600000087577888
-
martedì 01 aprile
-
martedì 01 aprile
-
martedì 01 aprile
-
martedì 01 aprile
-
martedì 01 aprile
-
martedì 01 aprile
-
mercoledì 02 aprile
-
mercoledì 02 aprile
-
mercoledì 02 aprile
-
mercoledì 02 aprile
-
mercoledì 02 aprile
-
giovedì 03 aprile